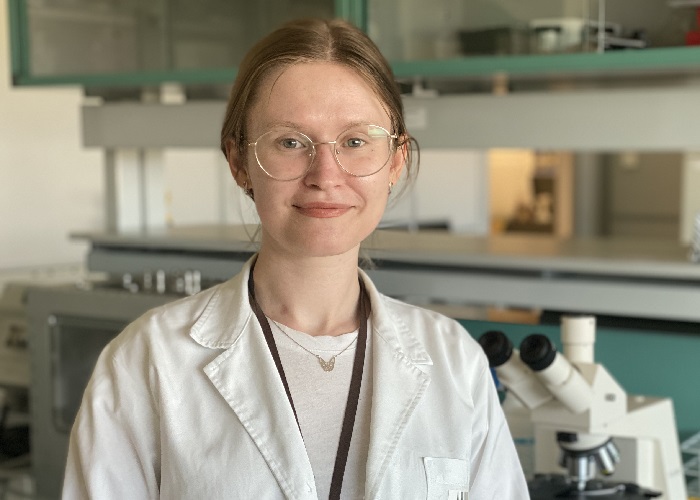VIAGGIO NEGLI OSPEDALI, DOVE IL DONO SALVA LA VITA / Parte 2
I COORDINAMENTI OSPEDALIERI PER I TRAPIANTI, OPERATORI SPECIALIZZATI ALLE PRESE CON LA SFIDA PIU' GRANDE: LA RELAZIONE CON LE FAMIGLIE DEI DONATORI
Non è la prima insegna che incontriamo in ospedale, difficile scorgerne l’etichetta in ascensore. Eppure è un’équipe presente quasi in ogni plesso ospedaliero, impegnata a salvare vite, a lavorare in urgenza. E nella bufera in cui il coronavirus ci ha trascinati, non ha mai smesso di operare per restituire alla vita centinaia di pazienti. E’ l’équipe del Coordinamento Ospedaliero per i Trapianti: un medico e un team di infermieri, esperti in medicina d’urgenza ma anche in molti aspetti relativi al fine vita, si prendono cura dei donatori selezionando chi potrà dare a qualcun altro una speranza di vita migliore attraverso la donazione di organi, tessuti e cornee, senza trasmettere rischi o patologie. Operatori specializzati in una scienza che si apprende ma non si insegna: il dialogo con le famiglie, chiamate a dire sì o no alla donazione.
5 PIANI DI OSPEDALE TRA L’ALFA E L’OMEGA.
Un sali e scendi di emozioni attraversa gli operatori del dono ogni giorno. Seguiamo Patrizia Ferian, infermiera di coordinamento, mentre lascia il suo ufficio al 5° piano dell’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso per passare in Ostetricia, dove una giovane mamma sta donando la placenta. Da lì verrà ricavata la membrana amniotica per la cura di patologie della vista e per altri mille usi in chirurgia. Patrizia per un attimo tiene in braccio il suo bambino. Solo qualche ora prima si trovava al piano “meno uno”. La parola “obitorio” suona come un brivido eppure anche quello è un luogo di cura: “Lo è davvero - racconta Patrizia - proprio ieri qui ho incontrato due persone anziane, sono tornata a casa con il ricordo dei loro capelli bianchi, nel volto il dolore lacerante per un ragazzo che non c’era più. Il loro sì alla donazione è stato come un urlo soffocato, pareva mi dicessero “vi prego fatelo”, quasi fosse una risposta per non lasciarsi sfuggire quel piccolo germoglio di vita. Anche nei casi più estremi, persino di fronte al suicidio, donare può lenire il dolore, è una pillola che ne calma una parte, è il gesto che resta perché non tutto sia perduto. I colleghi in ospedale me lo dicono spesso: tu sei quella dell’Alfa e dell’Omega, viaggi tra la fine e l’inizio della vita”.
QUALE ALTRO MESTIERE, SE NON QUESTO?
Un bagaglio di emozioni non facile da gestire, anche da operatori. “Ricordo una famiglia e un colloquio davvero complicato, coniugi che non si parlavano, un giovane stroncato da un incidente in moto a 220 chilometri orari – racconta Barbara Franzoi dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre. Anche lei infermiera, come molti altri in prima linea -. Ci ho messo due ore per riuscire ad entrare in comunicazione con loro, alla fine quella frase: siamo qui per chiedervi se vostro figlio in vita ha mai parlato di donazione, perché potremmo ancora salvare i suoi tessuti, dissi. “Salvare” è una parola viva. Da lì si può pensare alla vita, davvero forse non è stata una morte vana. Incontro familiari che a distanza di anni hanno vissuto la donazione come un dono”.
Perché una persona possa diventare donatore occorre però analizzare la sua condizione per escludere ogni rischio di trasmettere malattie, ogni donazione diventa così un nodo da sciogliere, di conoscenze prima, di relazioni poi. “Dopo vent’anni di trapianti nulla all’interno dell’ospedale è più appagante per me. Nonostante le difficoltà, lavorare qui resta un percorso di vita” continua Barbara, “come professionisti esploriamo moltissimi ambiti, siamo infermieri ma sappiamo porre le domande giuste, indagare tra una patologia e l’altra, studiare le cartelle: infondo, nessun campo ospedaliero ti permette di spaziare tra una disciplina e l'altra come il nostro".
...continua...
VIAGGIO NEGLI OSPEDALI, DOVE IL DONO SALVA LA VITA / Parte 3

MEDICI A SCUOLA DI EMOZIONI.
Analizzare cartelle cliniche, conoscere a fondo patologie e risvolti medici per individuare un donatore idoneo o compatibile che permetta alla vita di qualcun altro di continuare. Ci vuole tecnica, ma non solo. “Per dirla con un termine fin troppo abusato, ci vuole empatia” afferma la dottoressa Marzia Bellin, a capo del Coordinamento per i Trapianti di Ulss 3 Serenissima, “l’essere medici e operatori autorevoli, chiari e professionali ma “con le braccia aperte”, nel delicato equilibrio in cui siamo sempre immersi: da un lato la correttezza professionale e il giusto distacco con le vicende che incontriamo, dall’altro la capacità di dare tempo ed energie alle emozioni altrui, tenendo un canale sempre aperto verso famiglie che stanno soffrendo e ti fanno entrare nelle loro vite”. La dottoressa Bellin ricorda i sorrisi e le battute vissute con alcune famiglie dopo l’assenso alla donazione, le frasi scandite lentamente, la spalla su cui molti si sono appoggiati, gli abbracci dati quando ancora era possibile avvicinarsi. Nel caso della donazione d’organi, è difficile per le famiglie riconoscere che un fratello, un figlio, una madre non c’è più anche se è sdraiato a letto di fronte a loro e pare che respiri. “L’esperienza della morte cerebrale nella donazione d’organo è complicata, richiede uno sforzo per essere capita” spiega la dottoressa Elena Momesso del Coordinamento Trapianti di San Donà per Ulss 4 Veneto Orientale. E quest’anno si è aggiunto un ingombrante ostacolo in più: il Covid.
IL DONO AL TEMPO DEL COVID.
L’équipe della dottoressa Momesso si è divisa fin dal primo lockdown tra gestione delle donazioni e il Covid Hospital di Jesolo: “Quest’anno c’è stata un’ulteriore difficoltà nella comunicazione, i familiari non possono stare al letto dei pazienti, le notizie arrivano solo per telefono. Ricordo le famiglie e la loro sofferenza – continua la dottoressa Momesso - la figlia di una signora mi ha richiamato questa estate perché voleva riparlare della mamma diventata donatrice durante il primo lockdown: era contenta della scelta di donare ma non era riuscita ad elaborare il lutto perché, abitando in un’altra regione, non l’avevamo potuta accompagnare. Nonostante questo, la sensibilità e solidarietà delle persone è continuata. Questi familiari hanno trovato ugualmente la forza e il senso civico di dire sì”.
Tante altre famiglie, invece, non ce l’hanno fatta. In Italia il tasso di opposizioni alla donazione nei primi mesi del 2020 è cresciuto, in un contesto ospedaliero simile in certi momenti ad un fortino inespugnabile in cui anche il dolore di una famiglia non trovava spazio. “E’ stato il grande dramma del Covid vissuto in Rianimazione, che credo di non aver ancora smaltito – racconta la dottoressa Bellin – nei momenti peggiori di diffusione del virus non abbiamo avuto molti donatori, vedevamo gli occhi smarriti delle famiglie, arrivate spesso sfinite al termine del decorso della malattia”. Quel che manca di più adesso, racconta, è proprio la comunicazione con le famiglie: “In tempi normali la sala in cui si comunica il decesso e si fa la proposta di donazione si riempie anche di sette o otto familiari. Il fratello, la moglie, la cognata, i figli: spesso facciamo firmare l’assenso alla donazione anche ai ragazzi di 17 o 18 anni in aggiunta all’avente diritto, per incontrare il loro desiderio di condividere questo gesto – continua Marzia Bellin -. Dopodiché, noi medici e infermieri usciamo dalla stanza. Perché bisogna uscire, dobbiamo farlo”. Aperti ad accogliere storie incredibili di pazienti e familiari, senza mai farsi travolgere né mettersi sullo stesso piano: “Una delle mie prime volte dissi a una signora che aveva perso la figlia “la capisco”. La sua reazione fu terribile e mi aggredì, non ho mai più fatto lo stesso errore”.
Articoli Correlati

"Con le cornee destinate alla ricerca abbiamo rivoluzionato i trapianti"

"Quella telefonata, le mie lacrime di gioia. La donazione ha trasformato il dolore"

2021, il 62% dei trapianti di cornea italiani realizzati con cornee dal Veneto

Auguri speciali. Non potendo parlar sempre di Coronavirus...

Barbara, campionessa di Pallavolo: "Sono qui perché il trapianto è vita"

BRUCIORE, PRURITO, OCCHI ROSSI: COSA FA IRRITARE GLI OCCHI IN QUESTO PERIODO?

DONO E RICERCA: I FONDAMENTI DELLA MEDICINA RIGENERATIVA

ECCO PERCHE' ALCUNI TESSUTI VENGONO DESTINATI ALLA RICERCA

FRATELLI E SORELLE SOLIDALI, TRA PANDEMIA E CULTURA DEL DONO

GIUSY VERSACE: QUELLA FRASE SUL DONO HA ACCESO IN ME UNA SCINTILLA
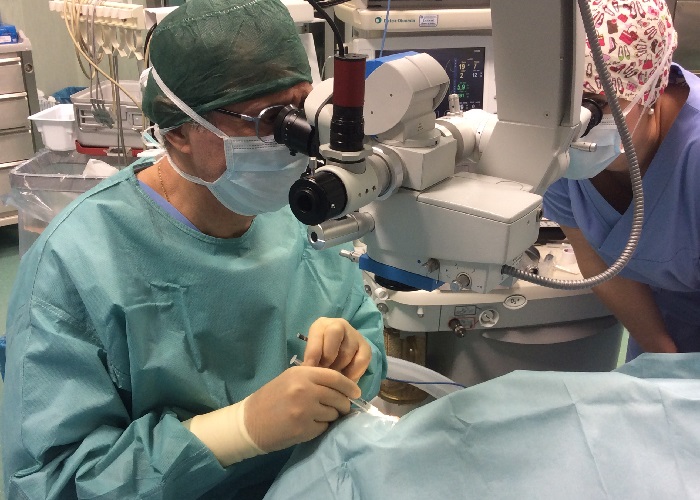
Il prof. Busin, dalla cornea artificiale alla cibernetica oculare. A cosa punta la ricerca

In Veneto 1 donatore di cornea su 5 si è espresso in vita

L'URGENZA DEL DONO. E l'importanza di assistere i familiari anche in un'epidemia

LA FORZA DEL DONO E IL NOSTRO ESSERE COMUNITA'

Noi operatori della Medicina delle Donazioni, che curiamo pazienti che non conosceremo mai...

Rassegna Vvox - Occhio alla vista web fest
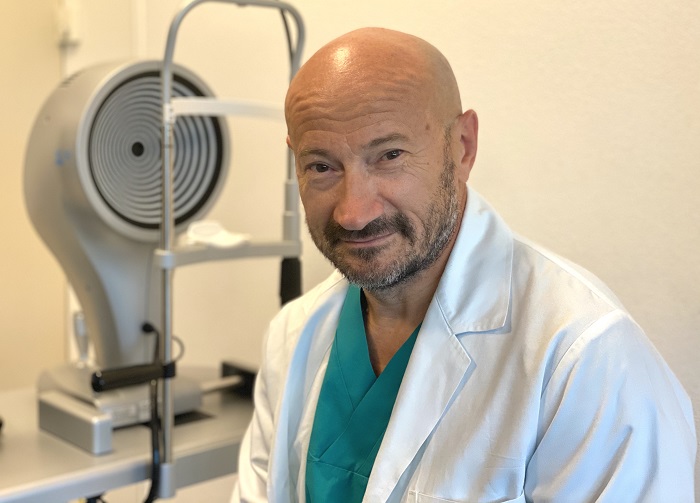
SIBO, DIEGO PONZIN NUOVO PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ITALIANA BANCHE DEGLI OCCHI